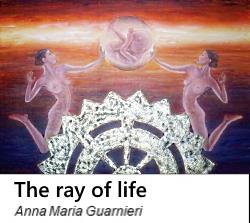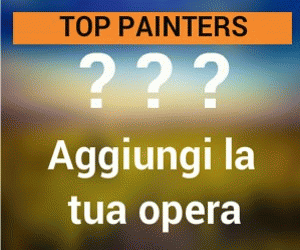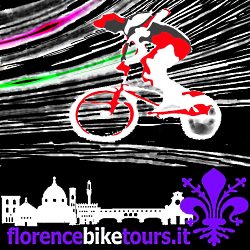Pitture e artisti |

Storia dell'arte intorno al 1400 - XV secolo
Storia dell'arte intorno al 1400 - XV secolo. Nel 1400 prende corpo il metodo prospettico, ovvero un nuovo modo di concepire e rappresentare visivamente lo spazioANNO: 1100 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
 Nel 1400 prende corpo il metodo prospettico, ovvero un nuovo modo
di concepire e rappresentare visivamente lo spazio. Non è a caso che questo nuovo modo
di riprodurre illusoriamente la profondità si afferma quando la società
borghese è nel pieno del suo sviluppo.
Nel 1400 prende corpo il metodo prospettico, ovvero un nuovo modo
di concepire e rappresentare visivamente lo spazio. Non è a caso che questo nuovo modo
di riprodurre illusoriamente la profondità si afferma quando la società
borghese è nel pieno del suo sviluppo.
Le contese fra le Signorie confinanti
portato in questo periodo all'affermazione di grandi famiglie (i
Medici a Firenze,
gli Estensi a Ferrara, i Gonzaga a Mantova ecc) e i maggiori stati italiani,
compreso lo Stato della Chiesa, raggiungono un equilibrio di forze
che impedisce il prevalere di uno di essi su tutti gli altri. Il maggior
benessere di questo momento storico determina quindi un nuovo desiderio
di conoscere e sperimentare il mondo e la natura; gli uomini provano
fiducia nella propria libertà e nella capacità di creare opere importanti e
durature.
Le nuove idee sull'uomo e sulle possibilità della sua intelligenza
favoriscono la nascita dell'Umanesimo proprio nella città di
Firenze, che era stata in questi secoli il centro
della spinta al rinnovamento. Un particolare sviluppo di espressioni
artistiche coinvolge la società borghese e questo sviluppo proseguirà
anche nel secolo successivo, incidendo profondamente nella cultura
occidentale e prendendo il nome di "Rinascimento".
Il termine "rinascimento" identifica quindi l'arte sviluppatasi nei
secoli XV e XVI, anche se fu usato per la prima volta da Jacob Burckardt
nella sua pubblicazione 'La
 civiltà del rinascimento' del 1860, prima di
lui Giorgio Vasari nel descrivere i cambiamenti e le novità che si
verificarono a partire dal trecento, usa il termine 'rinascita'.
civiltà del rinascimento' del 1860, prima di
lui Giorgio Vasari nel descrivere i cambiamenti e le novità che si
verificarono a partire dal trecento, usa il termine 'rinascita'.
Questa
nuova corrente di pensiero si afferma anche nelle grandi città inglesi,
francesi, nei Paesi Bassi ed in Germania: la sua diffusione è facilitata
anche dall'invenzione della stampa a caratteri mobili (1450). Tuttavia il
decennio fondamentale per il cambiamento del gusto artistico a livello
europeo è, sia in Italia, sia nei Paesi Bassi (patria dell'arte
Fiamminga), quello compreso tra il 1420 ed il 1430. Caratteristica peculiare del
rinascimento fu l'interesse per tutte le manifestazioni culturali del
mondo antico, gli artisti rinascimentali si sentivano legati alla civiltà
classica e consideravano il medioevo un'età di decadenza.
L'arte intorno
al 1400 rivolse quindi il proprio sguardo al mondo classico non
semplicemente per imitarlo, ma partendo da esso per creare qualcosa di
nuovo. In questo periodo storico molti artisti si recavano a
Roma per studiare le opere classiche, mentre
Firenze fu un centro molto fiorente
grazie alla presenza di molte famiglie che commissionavano opere d'arte,
in particolare la famiglia Medici con Lorenzo il Magnifico. Partendo dal
presupposti che l'arte classica è un'arte naturalistica e lo scopo
dell'arte è imitare la natura, in questo periodo si intensificano gli
studi sulla natura. Da questi studi ne consegue un diverso modo di
indagare la realtà che circonda gli artisti, ne sono il frutto la
scoperta della prospettiva e delle proporzioni. Inoltre alcuni artisti
scrivono trattati sull'argomento come Leon Battista Alberti il quale nel
1435 terminò la stesura del suo 'De Pictura', oppure Piero della
Francesca che scrisse il 'De prospectiva pingendi'.
Il
bisogno di stabilire regole fra le parti, per ottenere l'armonia dell'insieme,
si traduce anche nello studio delle proporzioni, che definiscono le
dimensioni delle parti del corpo. L'arte esplora quindi l'anatomia e
la natura, e diventa scienza: le prime scoperte sulle scienze naturali
sono dovute agli artisti e proprio un artista come
Leonardo da Vinci,
inizierà un'indagine sistematica del corpo umano e dei fenomeni legati
al moto. La consapevolezza di essere i protagonisti della storia determina
anche l'interesse per le testimonianze dell'antichità, che vengono
riportate alla luce da scavi sistematici, per poter esser studiate; l'amore
per l'antico non si risolve nell'imitazione delle opere del passato,
ma avvia alla ricerca di modi espressivi originali, che rielaborano gli
ordini classici, come l'arco a tutto sesto e il frontone sulla facciata
delle chiese.
 La riforma artistica fiorentina iniziata con Donatello,
Brunelleschi, Leon Battista Alberti e Masaccio, prosegue con l'opera di
grandi artisti quali Paolo Uccello, Luca della Robbia, Filippo Lippi,
Andrea del Castagno e il Verrocchio, per finire con l'opera di
Botticelli
che rappresenta il sorgere della nuova cultura filosofico-scientifica del
Cinquecento.
La riforma artistica fiorentina iniziata con Donatello,
Brunelleschi, Leon Battista Alberti e Masaccio, prosegue con l'opera di
grandi artisti quali Paolo Uccello, Luca della Robbia, Filippo Lippi,
Andrea del Castagno e il Verrocchio, per finire con l'opera di
Botticelli
che rappresenta il sorgere della nuova cultura filosofico-scientifica del
Cinquecento.
A Urbino è attivo Piero della Francesca, a Padova opera Andrea Mantengna, a
Perugia dominano il Perugino e il Pinturicchio, a
Milano c'è il Bramante e a Venezia sono attivi Giovanni Bellini,
Antonello da Messina e il Carpaccio.
La pianificazione del territorio è
un fenomeno tipico del Quattrocento, così come la pianificazione della città.
Nei trattati di Architettura vengono studiate città ideali, al centro
delle quali una grande piazza diventa quasi la corte d'onore del palazzo
signorile, con porticati lungo il perimetro ed un monumento al centro. Da
questa piazza le strade si dipartono secondo tracciati geometrici a
raggiera o a scacchiera. Sarà in questo periodo che Roma comincerà
lentamente a riconquistare il suo ruolo storico, grazie anche ai papi
Niccolò V e Sisto IV (1471-1484) che chiameranno in Vaticano, artisti da
ogni parte d'Italia, molti dei quali lavoreranno alla Cappella Sistina
(Perugino, Botticelli,
Pinturicchio, Signorelli, Ghirlandaio, Piero di Cosimo).